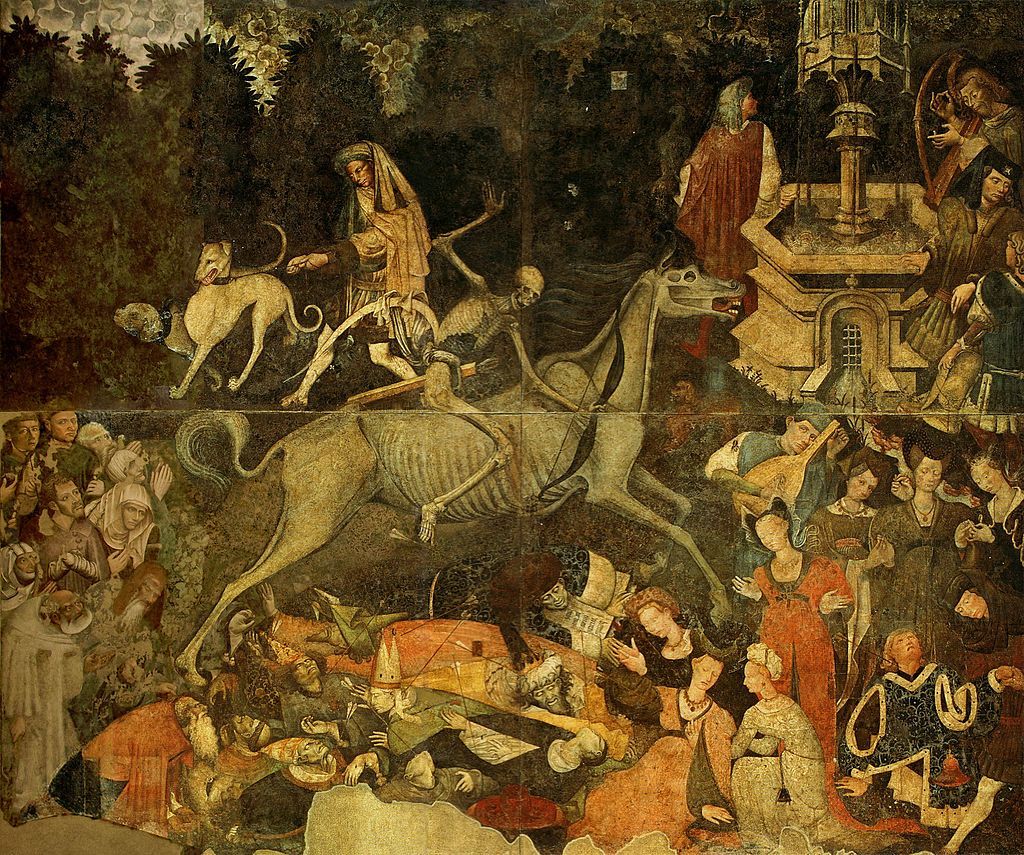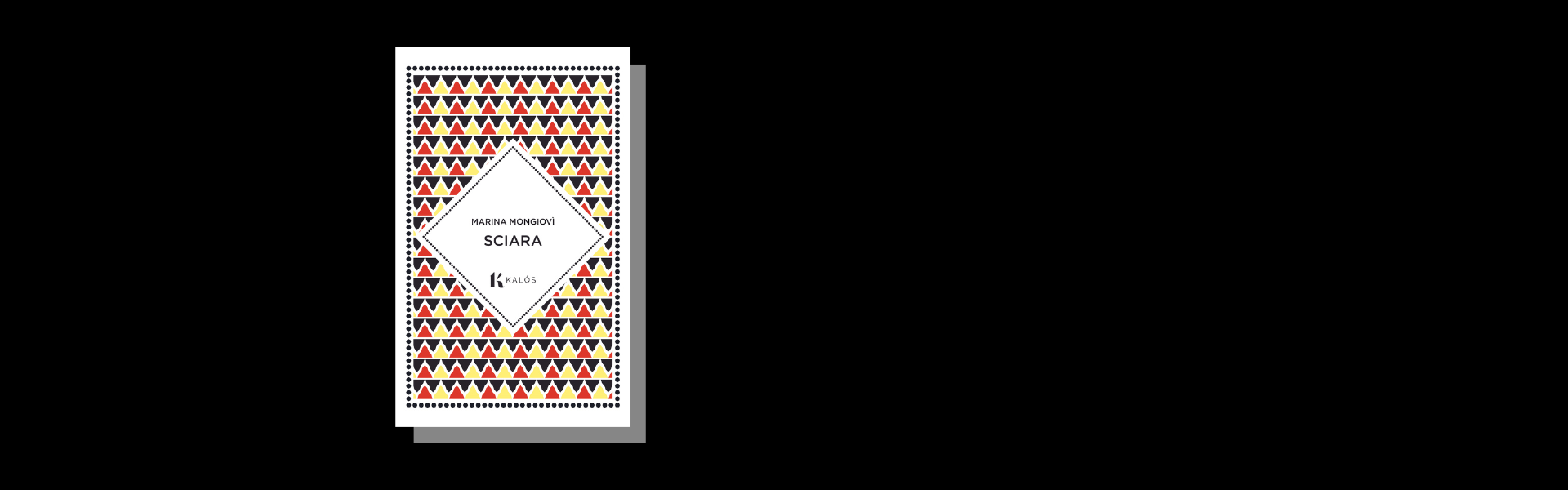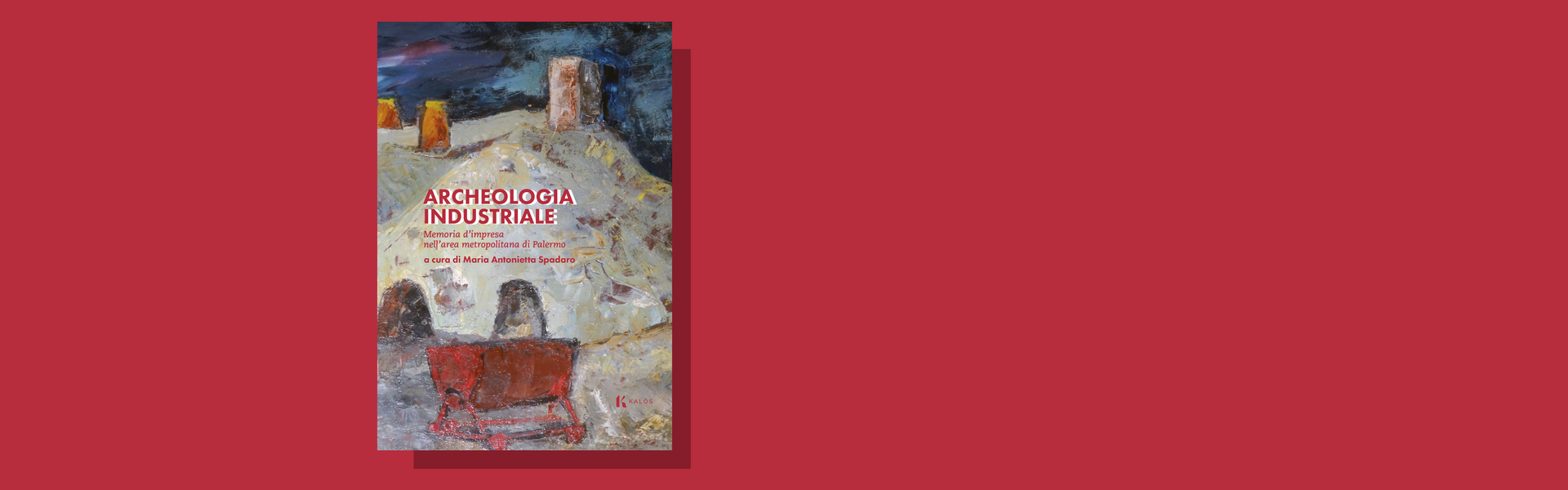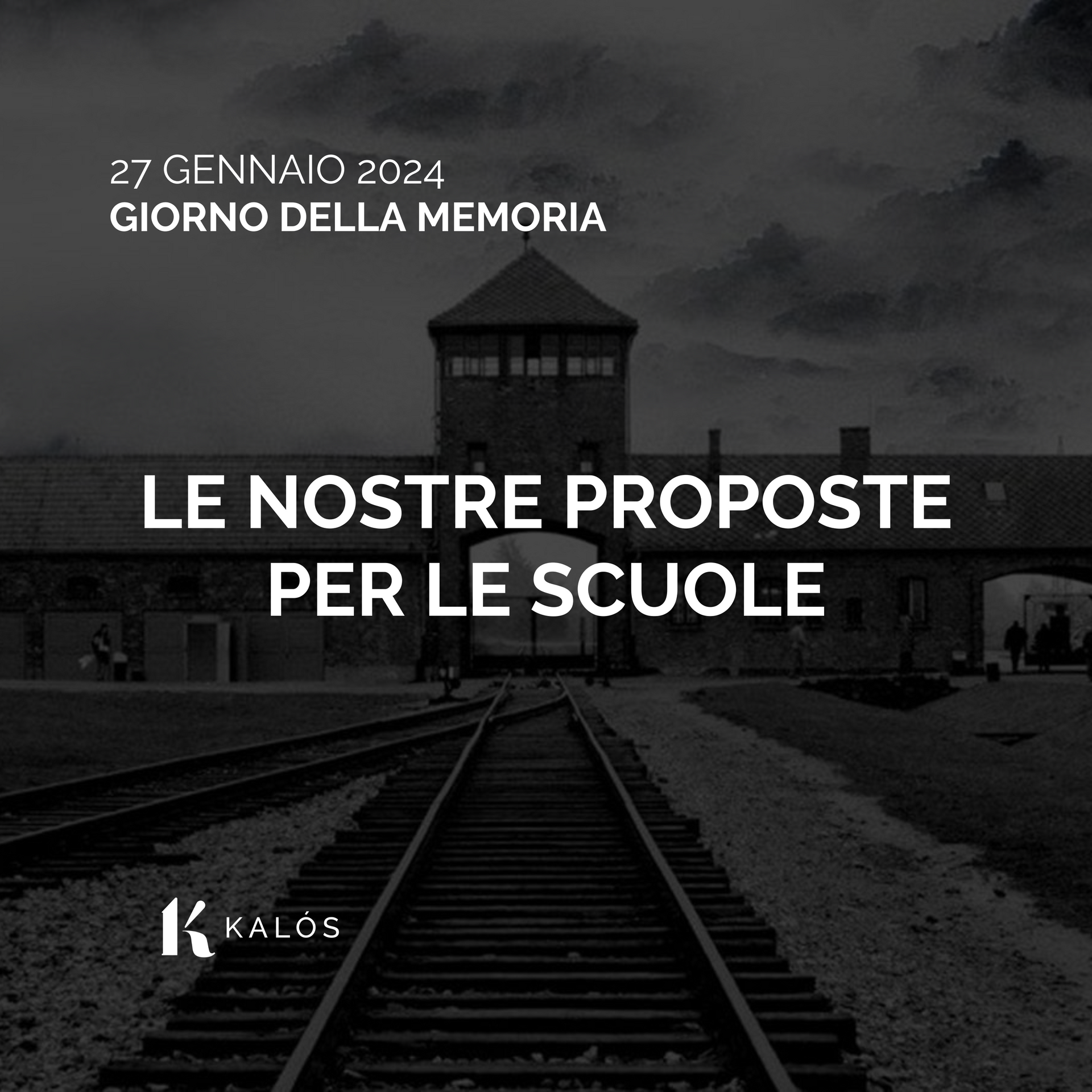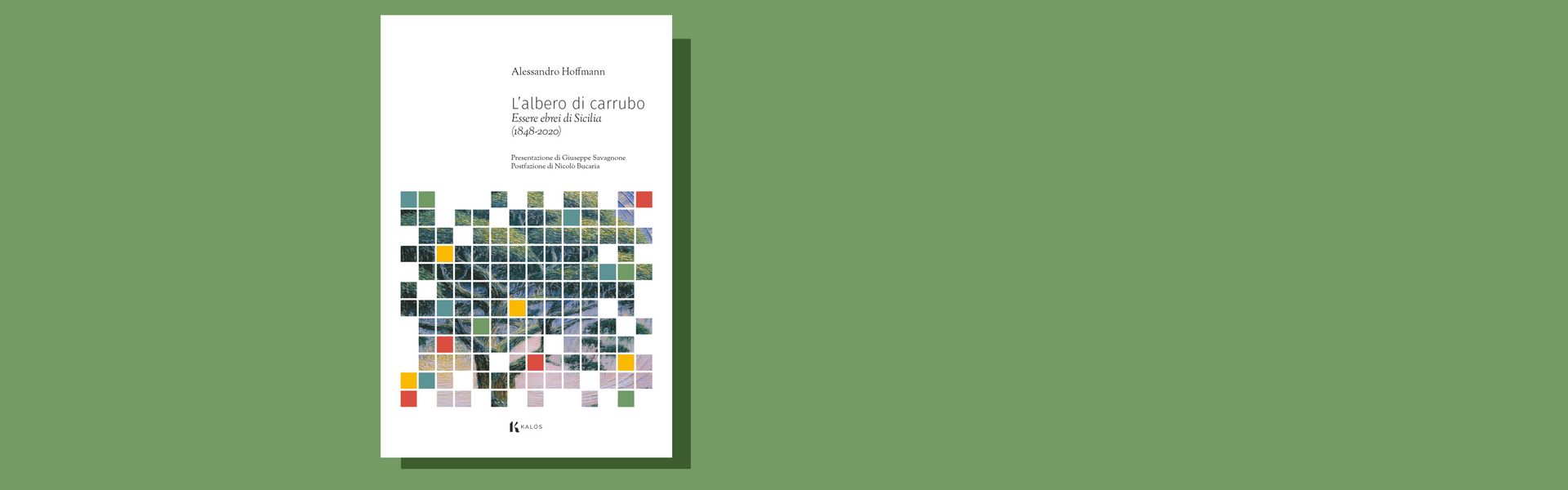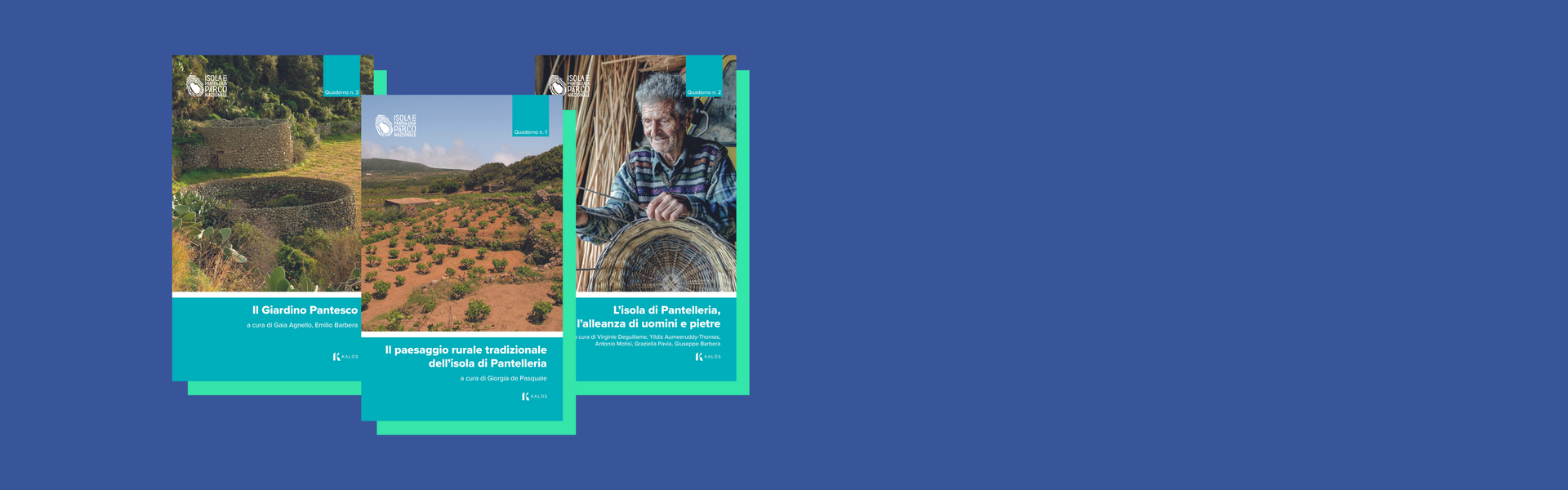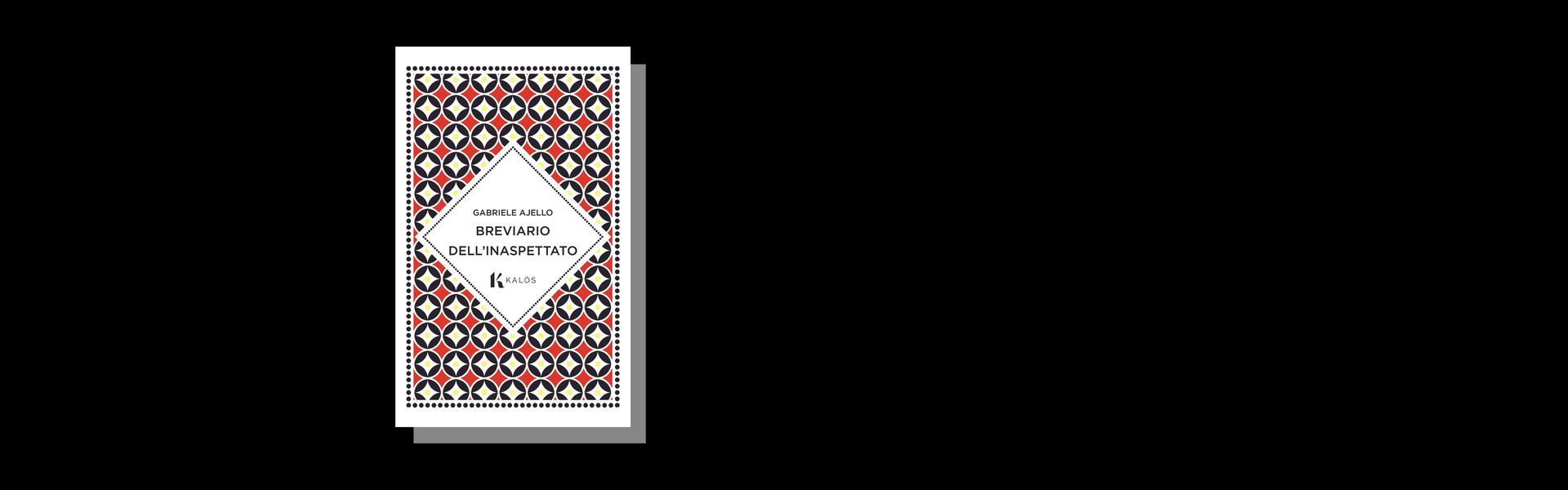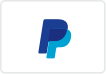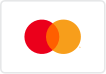La fine del Cinquecento fu un periodo particolarmente difficile per la città di Palermo: due ondate di peste fecero cadere la città nel panico, provocando in totale circa 3.500 vittime in appena 11 mesi.
Leggiamo cosa accadde, attraverso le parole di Francesca Giurleo tratte dal suo ultimo libro
Petru Fudduni.
"Tutto era iniziato la mattina del 9 giugno 1575, quando, nel quartiere di San Domenico, era stato ritrovato il
cadavere di una meretrice, detta “la Maltesa”, che aveva trascorso una notte con un mercante di tappeti infetto, capitano di un brigantino, ripartito subito dopo col suo vascello.
Lei si era subito ammalata, morendo dopo circa cinque giorni, ma nel frattempo aveva contagiato un suo frequentatore, un certo De Panicola, che a sua volta aveva infettato
tutta la sua famiglia.
Il Senato palermitano dapprima non si preoccupò molto, infatti nella città il male si confondeva facilmente con
altre patologie presenti e il numero dei morti, già elevato, ora non destava alcun sospetto,
poi però quando alcune genti di Palazzo Adriano e Giuliana si spostarono a Palermo la virulenza del male diventò incontenibile, mettendo in evidenza la gravità della situazione.
L’11 giugno l’Autorità locale si rese conto della tragedia in cui era incappata la città e cercò allora di prendere le precauzioni del caso;
apparve chiaro che il contagio portato dalla nave proveniente dall’Africa – le voci popolari parlavano di Tunisi o Alessandria d’Egitto – approdata sulle coste della Sicilia
si era diffuso nell’intera isola, quindi con una prima ordinanza
stabilì la chiusura del porto e di tutti gli ingressi alla città stessa."
Nonostante le precauzioni, il contagio non cessava e le Autorità decisero di dare
pieni poteri a un noto luminare, Gian Filippo Ingrassia,
che
con una équipe di dottori prescrisse una serie di obblighi a tutta la cittadinanza.
Tutti dissero di non aver mai visto, nella loro carriera medica, un morbo così contagioso e letale fu ordinato che gli infetti rimanessero serrati nelle proprie case prima di passare in uno dei nove lazzaretti realizzati in città. Il primo lazzaretto
venne allestito nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo, sostituito poi dalla
Cuba, palazzo reale di origine saracena posto in un giardino fuori dalla città, ricco di acqua e assai arioso.
"Qui l’Ingrassia stabilì che i malati, divisi fra uomini e donne in due edifici contraddistinti,
venissero separati
dai convalescenti, i quali potevano tornare alla loro piena attività dopo due mesi dalla scomparsa della febbre.
Stabilì poi che i conventi di San Domenico e San Francesco, i più importanti luoghi religiosi della città,
restassero isolati. Era accaduto infatti che i frati, i quali andavano in giro per le strade e le case a portare il loro conforto, si erano contagiati l’un l’altro e costituivano un serio focolaio di quel morbo letale che dilagava a dismisura.
Vietò dunque ogni adunanza, ogni celebrazione religiosa e stabilì ancora che tutto ciò che era appartenuto a gente infetta venisse bruciato.
Intere case vennero dunque smantellate e dovunque per le vie erano roghi di letti, materassi, biancheria, nel caldo torrido dell’estate che avanzava e rendeva
l’aria irrespirabile.
Il male sembrava comunque non voler cessare e la superstizione cominciò a farsi strada; si accusarono i medici di aver tutto l’interesse a non trovare le cure adatte ad annientare il morbo per non voler perdere le loro alte parcelle, e fu allora che il Dott. Ingrassia ebbe un comportamento estremamente encomiabile rinunciando al suo stipendio e prodigandosi personalmente a soccorrere gli ammalati. Fu
seguito nell’esempio dai suoi aiutanti medici, alcuni dei quali vennero contagiati e morirono.
Solamente nel maggio 1576 la situazione tornò sotto controllo e non si registrò più alcun contagio."
A un anno di distanza, l’11 maggio 1577 verrà poi registrato un focolaio
nel convento della Martorana, che provocherà, in quattro mesi, più di 400 decessi.
Le suore, infatti,
avevano avuto contatti col mondo esterno per l’acquisto delle materie prime per i loro dolci e si erano sottratte dunque all’obbligo di isolamento, rendendosi così complici della nuova, terribile, ondata di decessi...
Per rimanere sempre aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter, compilando il form che trovi in fondo alla home.
Seguici su Facebook, Instagram e Youtube.